È vero, nasce come emanazione dei brunch di Villa Maria Luigia, la guest house di Massimo Bottura appena fuori Modena, ma questo Gatto Verde è anche il primo locale dopo l’ammiraglia Francescana ad essere totalmente concepito dal due volte miglior chef del mondo e dalla sua storica compagna Lara Gilmore, senza altri partner più o meno ingombranti. Niente Ferrari come nel caso del Cavallino di Maranello, per esempio, né Gucci con le sue patinate Osterie. Potrebbe quindi essere un’occasione unica per capire lo stato dell’arte del Bottura pensiero, alleggerito dalle dinamiche un po’ paludate della sua insegna tristellata e in uno spazio ampio e multifunzionale. Il primo messaggio forte viene dalla scelta della responsabile di cucina: Jessica Rosval, canadese classe 1985 e già resident chef della villa-galleria d’arte, a cui è stato affidato il compito, sulla carta decisamente complicato, di creare un filo conduttore tra gli Stati Uniti e l’Italia.
Ci riuscirà? Vi spoilero già la risposta, ed è sì. Ci riesce grazie al linguaggio universale (e modaiolo, va detto) della brace e dell’american BBQ, i cui elementi caratteristici vengono isolati e ricollocati con intelligenza. Forse una strada più semplice che tentare di rendere il clam chowder il centro del mondo culinario (come in “We are all connected under one roof” in Francescana), ma a mio modesto parere più riuscita.


Chi cucina materialmente non sarà Massimone nazionale, ma non possiamo dimenticare che per apprezzare al meglio la cucina Botturiana bisogna aver presenti le influenze artistiche che lo ispirano al momento. In questo caso l’intento è esplicitato dal quadro che domina la sala, uno dei Not a Pollock di Mike Bidlo, artista americano celebre per i suoi “pezzotti” d’autore, trasmesso in cucina attraverso il tema, appunto, del “non è”: al di là del generico “non è un BBQ” che sottende il percorso degustazione nel suo complesso, offre spunti interessanti in quasi tutti i piatti.
Si parte, dobbiamo notare, con qualche intoppo. Dalla carta degli aperitivi opto per un Negroni passato in botte: l’idea è golosa, ma una botte un po’ malandata aveva lasciato al drink un sentore tra il tappo e il solvente. Faccio presente, prenderanno atto. Oltre a questo, almeno una cialdina sarebbe stata d’aiuto per accompagnare la bevuta; non che sia il primo Negroni che butto giù “solista”, ma avrei gradito un supporto.
TÒLA DÒLZA


L’intro è tutta dedicata a Villa Maria Luigia, e si parte con coerenza, dando ad ogni elemento un tocco di fiamma, dalla focaccia iper-idratata, al suo companatico: gli spinaci bruciati nella rivisitazione dell’erbazzone, l’olio di cedro nell’hummus di mandorle, la maculatura da pizza napoletana sulla ricotta di Rosola, passata per l’appunto nel forno a legna e rifinita col miele della Villa.
NON È UNA COZZA

Non che l’avessimo scambiata per tale, ma il tema del “non è” va rispettato. E in effetti non è solo una crocchetta, non è un crab cake, è un riassunto di consistenze adriatiche di granchio blu (poteva mancare?), capesante, mazzancolle, l’ancora territoriale della pancia di maiale, croccantezza sonora e una cortese ambientazione bruciacchiata, nonostante il total black che l’avvolge ed è ricavato dalle mele. Questo del “bark” (la crosta di spezie estremamente brunita che dovrebbe avvolgere ogni buon pezzo di BBQ americano) ricostruito è una delle firme della Rosval, e lo rivedremo. Anche sull’acidità della sour cream si spinge poco, ma ci sta: la “non-cozza” non è fritta, la parte suina non è eccessivamente grassa, siamo all’inizio del percorso e non si cucina solo per i nerd, messaggio recepito.
BORLENGO DI ACQUA DI PORCINI

Nessun effetto speciale, nessun trompe-l’oeil, questo Borlengo è un Borlengo. Orgoglio modenese da ben prima che venisse coniato e inflazionato il termine street food, sono delle sottilissime crespelle di sola acqua e farina, di solito farcite con pesto di aglio e Parmigiano. Qui nella “colla” (così i mastri borlengai chiamano amichevolmente il loro impasto) all’acqua si sostituisce un brodo di funghi molto concentrato, e si servono con porcini grigliati e abbondante tartufo. L’esecuzione è inappuntabile, la crespella è della consistenza perfetta per essere mangiata con le mani senza imbarazzanti cedimenti strutturali, la quantità di funghi e tartufo al limite del dopante, roba da aprire una catena di locali che serva solo questi: chi non apprezza un piatto del genere ha una pattumiera al posto del cuore. E a proposito di pattume, questa dotta citazione mi ha riportato al sacco nero della monnezza malinconicamente seduto a fianco dell’ingresso. Ovviamente “non è” lì in attesa del ritiro dell’umido, ma è una riproduzione in bronzo, opera dell’autore Gavin Turk e che mi sembra di aver visto in Francescana qualche anno fa.


Ci prendiamo una pausa dalla degustazione per fare un giro in uno degli spazi che Gatto Verde condivide con la Guest-house: un ambiente un po’ surreale, in cui si attraversa un’esposizione di Ferrari, un indefinito numero di moto Ducati che sembrano spuntare da ogni angolo, e vari pezzi d’arte delle precedenti esposizioni in Francescana hanno trovato nuova collocazione. Imbattersi in uno spin painting di Hirst o in una statua iper-realista di Duane Henson fa un po’ specie in quella che è -tutto sommato- la strada per il bagno. Invidio chi ha la cultura artistica sufficiente per identificare tutte le opere, un comune mortale venuto per mangiare potrebbe sentirsi circondato dallo scanzonato edonismo del loft di Jerry Calà in “Vado a vivere da solo”.
COTECHINO SANGUE DI DRAGO

Altro passaggio di emilianità alla brace, per un cotechino che “non è” un tonkatsu e che condivide con la non-cozza iniziale una sorprendente leggiadria nonostante le muscolose premesse. Concentrato, affrancato dal collagene e reso croccante, può interagire con una virtuosistica salsa agrodolce sorretta dalla sapidità finissima di un brodo dashi. Altro passaggio in cui troviamo un bark ricostruito, in questo caso una profumatissima non-panatura all’ibisco. Mi piace pensare che, essendo anche il primo passaggio di carne, Rosval abbia voluto mettere la sua firma da pit-master con uno smoke-ring totale e diffuso. (Dicesi smoke ring, quel bordo rosso vivo che dovrebbe avere la carne cotta al BBQ, firma di ogni appassionato).
AGNELLO DA MONTREAL A SAN DAMASO

Agnello che “non è” un brisket, anche se il bark ricostruito in questo caso mira proprio a dare quell’illusione, e “non è” nemmeno un kebab, nonostante lo spiedo. Sono fettine di agnello che trattengono la crosta di spezie grazie a una specie di maionese che fa il suo compito strutturale ma è poco incisiva nel sapore, si potrebbe sfruttarla meglio. L’affumicatura è ben presente e aromatica e la mostarda di pera fa le veci della senape in maniera ben più vivace ed elegante.
Apprezziamo anche la generosità della chef che invece di tenersi le “burnt ends” (i ritagli della carne particolarmente caramellati e bruciacchiati a fine cottura), come sarebbe prerogativa di chi presenzia alle braci, ce le offre in un bun ripassato nel forno a legna, rinfrescate con qualche foglia di coriandolo fresco. “Non è” un bao, me è uno dei bocconi più golosi della serata.
PASTA ARSA

Alziamo decisamente il tiro: “non è” un pre-dessert anche se la tendenza dolce e la posizione verso la fine del percorso indurrebbero a crederlo, “non è” solo un lavoro sulla parte croccante di una pasta (argomento già abbondantemente sviscerato da Bottura), “non è” un socarrat all’italiana, “non è” una pasta con le spuntature, nonostante le rifilature delle ribs cotte nello sciroppo d’acero. È soprattutto la sintesi e il culmine del lavoro di scomposizione del barbecue che è l’anima di tutto il menù degustazione. La tostatura della pasta crea l’effetto di un bark interiorizzato e diffuso, ma è soprattutto il fumo ad essere espresso in una nuova dimensione, non più solo aroma né sensazione trigeminale (quale è, al netto delle componenti aromatiche delle essenze usate) ma un nuovo gusto primario, elevato dal continuo confronto -boccone dopo boccone- con dolce, sapido e grasso. Un piatto che maschera grande concentrazione gustativa e concettuale sotto una coltre ruffiana di arancia candita, e vero metro delle possibilità di Rosval.
MELON LEMON

Torniamo sulla terra per un passaggio rinfrescante necessario: abbiamo pur sempre mangiato costine per pre-dessert, e quindi ben venga il melone bianco reso tenace dalla marinatura in sale e zucchero, la granita e la rifinitura con un liquore casalingo al limone e bruciato e ruta.
CIELO TERRA MARE

“Non è” -forse- un dessert tout-court, ma è sicuramente il piatto del viaggio. Gli occhi e l’olfatto sono dominati dalla rosa, in forma di yogurt al carbone e infuso in acqua di mare, al palato lampone, caviale (in quantità generose), e un biscotto all’alga nori a creare stratificazione aromatica e sensoriale. La sensazione marina composta di acqua, caviale e alga è tra le più complesse ed evocative mai assaggiate, pur non essendo l’ondata sferzante che ci si aspetterebbe da questi elementi. È mare, ma è sufficientemente delicato da mantenersi -letteralmente- in equilibrio con un fiore. Vale la pena approfondire il discorso su consistenze e strutture, vista l’ottima osservazione dell’autorevole firma di Dissapore che mi accompagnava: la particolare tenacità del biscotto, oltre a mantenere una parte croccante anche dopo l’inzuppo, implica una masticazione più meticolosa di quella che richiederebbe un dolce al cucchiaio, permettendo al caviale di esprimersi al meglio scoppiettando tra i denti. L’accoppiata tra lampone e rosa, frutto e fiore, acidità e linalolo è la parte ruffiana che ingolosisce e chiude un piatto perfetto e onirico, vera summa, insieme alla pasta arsa, della cucina di Gatto Verde.
Non si può dire che nell’Italia ideale di cui Massimo Bottura si fa promotore non si stia bene, soprattutto guardandola attraverso i suoi occhiali. Un’Italia boutique del mondo di eccellenze (visitare l’acetaia della struttura è illuminante in tal senso), crocevia internazionale di arte contemporanea e, soprattutto, esempio di integrazione gastronomica globale, così ispirata e consapevole da poter far convivere in armonia la più casalinga e materna cucina regionale, quella emiliana, con la più canzonata, quella americana. È abbastanza evidente che la clientela internazionale e danarosa di questo resort di campagna si trovi bene in questa cartolina, ed è oggettivamente difficile non subirne il fascino anche quando la si vive da semplici mangioni. Mi piace immaginare che dietro tutto questo mi aspetti il colpo di scena definitivo, il momento deus ex machina in cui Massimo, a mo’ di Julian Slowik, si palesa, batte le mani e svela il vero finale della performance ispirata da Mike Bidlo. Scoprire che, alla fine, tutto questo “non è”.
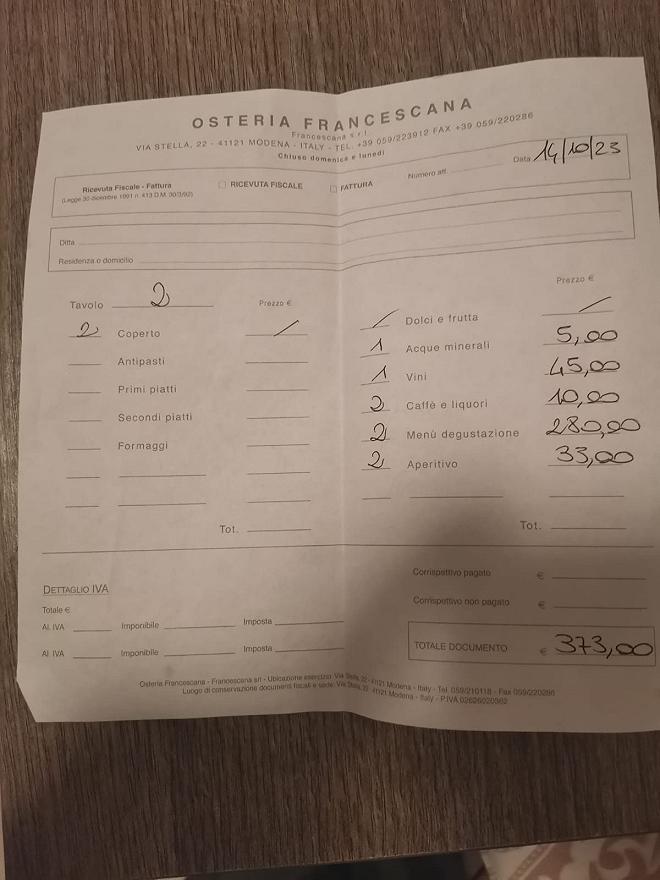
Opinione
Più che una succursale della Francescana, il Gatto Verde sembra l’espressione più pura e aggiornata della visione del mondo di Massimo Bottura, con tutto ciò che ne consegue.
PRO
- Una cucina coerente, golosa e perfettamente eseguita
- Carta dei vini dai ricarichi sorprendentemente morigerati
- Si vive in una galleria d'arte
CONTRO
- Qualche automatismo tra sala e cucina deve ancora collaudarsi
- Si vive in una galleria d'arte
