Vivo a Roma e me ne sono fatto una ragione: la carbonara originale non esiste, non è parte della nostra tradizione, per la verità. Vedete, Roma è una città bella e difficile. Vive di miti e di presunzioni, spesso confusi tra loro in un guazzabuglio insieme idiotico e suggestivo. A Roma la storia, l’archeologia, la fantasia si sfumano, una cosa nell’altra, come acquerelli in mano a un bambino. Roma sa di essere Roma, e proprio per questo lo sarà per sempre, e al contempo – da sempre – non è più quella di una volta.
A Roma il passato è sacro ed intoccabile dogma, irraggiungibile remota epoca aurea generata della stessa sostanza delle nebbie della memoria, sia che si parli di ruderi e storie di papi, sia che di più quotidiana “tradizione”. La tradizione è la festa de noantri, la tradizione è il cannone del Gianicolo che fa BUM a mezzogiorno – ma soprattutto a tavola, oh! Dal pollo coi peperoni a Feragosto, fino al cocomero mangiato ai baracchini ai bordi della Tiburtina e le caldarroste vendute dal racket degli ambulanti in piazza Navona, all’Epifania, al romano non toccargli la tradizione!
La tradizione, già: cos’è? Se chiedi in giro, la tradizione è il modo di fare le cose prescritto su immutabili tavole della legge dai grandi antichi. La tradizione è il binario dal quale non dobbiamo scostarci, pena svilire le nostre radici. La tradizione è il filo che ci collega a Remo e Romolo, financo a Enea. La tradizione è quella cosa che se sgarri dai binari sei un traditore della Patria, eretico bizzarro simoniaco qualunquista. La tradizione è quella cosa che faceva così mi nonna, perché si è sempre fatto così. La tradizione è quella cosa che faceva mi nonna, quindi si è sempre fatto così. Ma quindi de che? E se fosse un errore di percezione e quindi, anziché religione, queste ossessioni sulla tradizione fossero un mucchio di cazzate? Quanto sono antiche, davvero, le nostre tradizioni? Che sorpresa amara sarebbe, se riuscissimo a viaggiare nel tempo e scoprissimo che di alcune cose che reputiamo antichissime, anche in epoche abbastanza recenti, non esiste ancora traccia?
Che cos’è davvero la tradizione

Dice un adagio, “la tradizione è un’innovazione che ha avuto successo”. Ciò significa che alla radice di ogni cosa percepita come tradizione, c’è necessariamente un punto zero, un’invenzione, l’introduzione di qualcosa che ancora non esisteva o quantomeno, e più probabilmente, è un riadattamento di una formula pregressa. Questa nuova usanza, ricetta o piatto, supera la precedente ed incontra i gusti del substrato storico-sociale della sua epoca.
Riscontra quindi popolarità e gradimento; fino ad estendersi a macchia d’olio, divenendo di uso comune e pronta per essere trasmessa alle generazioni successive.
Perché si parli di tradizione, quest’ultimo passaggio è necessario: “tradizione” deriva da tradere, latino; “tramandare”. Essa è atto di trasmissione delle conoscenze che va intesa, fino a prima dell’avvento della scolarizzazione, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa, quasi come esclusivamente dipendente dai canali di comunicazione orale o pratico-empirici. In altre parole, prima che ci fossero i giornali gastronomici, La Prova del Cuoco e poi Internet, “la tradizione” non esisteva: esistevano semmai “le tradizioni”, quelle raccontate a voce da mammina e da nonnina e dalla vicina di casa, e ne esistevano tante quante erano le comunità, i paesi, i quartieri, le famiglie se non addirittura i singoli uomini e soprattutto donne che preparavano da mangiare in cucina; ciascuno con le proprie modifiche, adattamenti, varianti. La tradizione gastronomica così formata, inevitabilmente, non poteva essere il monolite univoco che intendiamo oggi; ma si presentava, per ciascun piatto, come mosaico di tutte le interpretazioni individuali del piatto stesso; considerate nel loro complesso.
Tali interpretazioni inoltre, naturalmente, erano passibili di tutte le alterazioni dovute al mutare delle condizioni sociali ed economiche che, da che mondo è mondo, regolano l’alimentazione e la gastronomia: disponibilità di specifici ingredienti, periodi d’abbondanza e carestie, condizionamenti politici, religiosi e legali.
In altre parole, se la bisnonna nel 1941 si svegliava una mattina e voleva fare la frittatina di pasta alla napoletana, ma non aveva il prosciutto o i piselli freschi, non è che andasse dal macellaio o nel campo a raccoglierli appositamente sfidando i bombardamenti: si rimboccava le maniche, si arrangiava con quello che aveva a casa, e se era brava le veniva buona lo stesso.
La tradizione come corpus unico e immutabile vincolato ad un rigido elenco disciplinare di materie prime ed ingredienti va quindi considerata un’invenzione della modernità, o meglio del secondo Dopoguerra, figlia della ricchezza seriale a portata di supermercato e dei manuali per cuochi provetti che hanno cristallizzato la pluralità delle voci gastronomiche in versioni univoche, ad alta tiratura e basso prezzo.
Ma da dove era partito tutto, perché questo lungo incipit sulla tradizione…? Ah già. Roma ed i suoi miti. Cari romani, oggi sono qui per smontarli. Sono armato di piccone.
Ed ovviamente con cosa me la prendo? Con la vostra ossessione-regina, con il piatto “della tradizione” per eccellenza, quello che se ci metti una cosa che nun ce va, o se manchi di inserirne una che pefforza, e se la cremina non viene giallo intenso scatta la crocefissione: oggi vi smonto la carbonara.
Storia della carbonara

Quando nasce la carbonara? Non mi dite “quando i pastori abruzzesi dell’Ottocento scendevano nell’Urbe per la transumanza con prodotti adatti al viaggio…” perché non ci sto. La storia ufficiale della cucina e della gastronomia si fa con i documenti e le attestazioni, cioè risalendo alla prima comparsa di un piatto e dei suoi nomi in un ricettario o nei menù dei ristoranti; non con le favole.
Su queste premesse, andando a ritroso nella storia, la prima comparsa di un piatto vagamente analogo alla carbonara risale al 1881: Francesco Palma, nel suo “Il Principe dei Cuochi”, introduce una pasta con uova, sugna e cacio. Simile, direte voi: è vero, ma ovviamente del nome “carbonara” non c’è traccia. Inoltre, se credete che il piatto sia patrimonio esclusivo dei Sette Colli, arrivano le dolenti note: sottotitolo del libro del Palma è, infatti, “La vera cucina napolitana”.
Per la prima attestazione del termine Carbonara, che cade stavolta effettivamente in area romana, bisognerà attendere più di settant’anni: il termine compare infatti per la prima volta su carta stampata nel 1950, in un articolo de La Stampa del 26 Luglio di quell’anno che racconta della partecipazione di Papa Pio XII alla festa de noantri trasteverina. Si legge: “Cesaretto alla Cisterna giura origini antichissime, essendo la sua osteria sorta sulle rovine di un’altra famosa ai tempi di Fabio Massimo. Fu questo oste ad accogliere per primo gli ufficiali americani giunti in Trastevere parecchi anni or sono in cerca di spaghetti alla carbonara”.
Ufficiali americani in cerca di carbonara: tenete bene a mente questa scena, è solo uno dei molteplici indizi che sembrano legare il piatto “romanissimo” all’ex-Nuovo Mondo.
Altro fattore determinante al riguardo è che la prima ricetta mai pubblicata della carbonara avvenga negli USA; sulla guida gastronomica “Vittles and Vice: an extraordinary guide to what’s cooking on Chicago’s Near North Side” di Patricia Bronté (1952).
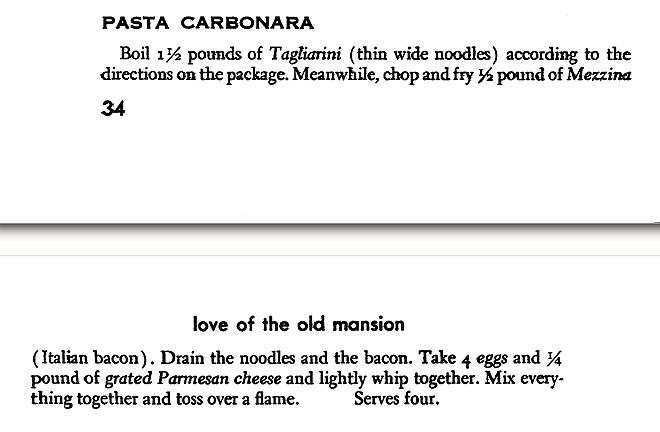
Tra le pagine della guida l’autrice recensisce il ristorante Armando’s, gestito dagli emigrati lucchesi “di ritorno” (cioè nati negli USA da genitori italiani, arrivati durante l’infanzia nello Stivale, e nuovamente rimpatriati oltreoceano durante l’adolescenza) Armando Lorenzini e Pietro Lencioni: la versione italoamericana, sorprendentemente simile a quella in voga ai giorni nostri e percepita come “tradizionale”, non presenta panna né altri orpelli; seppur venga preparata con la pancetta (definita “Mezzina”, con denominazione tipicamente lucchese) anziché con il guanciale e mantecata a caldo con un prevedibile effetto frittatina.
Prima ricetta per il nostro Paese è invece quella pubblicata sul numero di Agosto 1954 di La Cucina Italiana: la versione proposta farebbe alzare più di qualche sopracciglio ai talebani della carbonara di oggi; dato che suggerisce l’impiego di pancetta, uova intere, gruviera, aglio schiacciato e raccomanda di cuocere le uova “finché non si siano rapprese”.
Indignazioni a parte, due elementi spesso ignorati sono interessanti in questo documento per ricostruire l’evoluzione del piatto: il primo è appunto la cottura delle uova, onnipresente e a quanto pare imperativo per le carbonare dei tempi, che se da una parte avvicina l’immaginazione alle scrambled eggs e fornisce un ulteriore possibile indizio che spinge le origini del celebre primo vicine a una “pista americana”, dall’altro ci lascia capire come la concezione della tradizione come unità immutabile e inscalfibile sia un falso storico dettato dalla modernità.
Secondo elemento è la notazione “ricetta richiesta”, che lascia intuire che il piatto stia godendo in Italia di una crescente e trasversale popolarità, tale da portare i lettori delle riviste di cucina a chiedere chiarimenti sulla preparazione.
Da quel momento le apparizioni della carbonara sui ricettari si moltiplicheranno, dalle pagine di “La signora in cucina” di Felix Dessì (1955, con pancetta, uova intere, parmigiano) a quelle del mitologico “La grande cucina” di Luigi Carnacina (1960).
Saranno le parole del padre dei gastronomi romani a consacrare una volta per tutte, per il piatto, l’utilizzo del guanciale; che accompagnerà però una ricetta di nuovo molto lontana dal gusto contemporaneo e preparata con olio d’oliva, burro noisette, bucatini, parmigiano, uova intere cotte e, soprattutto, la panna (talebani… Ciao!); che accompagnerà le principali riletture d’autore del primo piatto che vi ha ormai spezzato il cuore fino agli anni Ottanta inoltrati.
Sempre merito del grande autore, probabilmente, il fatto che il piatto già presente trasversalmente in varie zone d’Italia si sia “romanizzato” fino a divenire pilastro fondante dell’identità cittadina.
Ma come e dove nasce, quindi, la carbonara? Per mano di chi? E cosa c’entrano gli americani? E qui subentra un ultimo, decisivo, tassello della narrazione. L’idea che il piatto sia nato come derivazione degli ingredienti a disposizione delle truppe alleate facenti parte della razione K, riadattati dall’ingegno di qualche brillante cuoco italiano che avesse dimestichezza con la pasta, è a lungo stata dismessa dai campanilisti oltranzisti dello spaghetto come ipotesi infondata e suggestiva.
Una voce ostinata e contraria al riguardo, è stata quella dello chef bolognese Renato Gualandi, classe 1921.
Gualandi ha sempre sostenuto di aver letteralmente inventato la carbonara, fornendo circostanze dettagliate e date precise, “Non è un piatto romano”, ha sempre detto: il piatto sarebbe nato, a suo dire, il 22 Settembre del 1944; in occasione di un pranzo ufficiale con i comandanti supremi dell’Ottava Armata britannica.
La pista americana
Il bolognese, cuoco ufficiale per le truppe angloamericane di stanza all’albergo Domus Mea di Riccione, si trova a dover allestire un pranzo per Sir Harold Alexander, comandante supremo di tutte le forze alleate in Italia, e per il luogotenente generale Oliver Leese; per festeggiare la liberazione di Rimini e Riccione.
Poco lontano però la guerra ancora incalza, le risorse sono limitate, e Gualandi improvvisa utilizzando quello che ha sotto mano presso il campo statunitense: rosso d’uovo liofilizzato, crema di latte (leggi: panna), un qualche tipo di formaggio, magari del parmigiano grattugiato, e infine il bacon. Ultima il piatto con una girata di pepe nero. È un successo: nasce la carbonara.
Gualandi diviene poi cuoco ufficiale delle truppe alleate di stanza a Roma (Settembre ’44 – Aprile ’45): in sette mesi il suo primo diventa di culto, grazie alla relativa facilità di preparazione e all’abbondanza degli ingredienti già in dotazione all’esercito USA.
La moda incalza: i militari in libera uscita a zonzo per la città frequentano le osterie e i ristoranti, chiedono in giro chi sappia cucinare quella pasta perfetta, forse tra i primi a recepire la novità c’è Cesaretto alla Cisterna. In base alle disponibilità degli ingredienti locali, a Roma, il bacon progressivamente diventa guanciale, il parmigiano, pecorino.
Proporre o non proporre il piatto in carta diventa una discriminante economica talmente importante, per i ristoranti romani che foraggiano l’esercito alleato, che l’oste cinematografico Giovanni Marchetti/Aldo Fabrizi chiederà su pellicola, all’aspirante cameriera Maria/Elsa Merlini nel corso di un’intervista di lavoro: “…Scusi un momento, senta un po’, ma lei li sa fare, gli spaghetti alla carbonara?” (in Cameriera bella presenza offresi…, Giorgio Pàstina, 1951).
Nel frattempo, qualcuno dei soldati presenti allo storico pranzo di Riccione è stato trasferito in Toscana: anche a Lucca si diffonde la ricetta, che comincia ad essere preparata con la pancetta locale anziché con il bacon. Il giovane Pietro Lencioni, che è venuto una decina di anni prima da Chicago con babbo e mamma, ne fa tesoro e si riimbarca verso gli USA per tentare la fortuna. Dopo una lunga gavetta in bar e club, aprirà con il socio Armando un ristorante italiano.
A Roma ormai la carbonara è dappertutto: Luigi Carnacina, intimo amico di Gualandi (che definì “uno dei più valenti chef europei”, e di cui curò la prefazione per alcuni ricettari), sceglierà di riproporre nella sua raccolta-capolavoro una versione il più simile possibile a quella del cuoco di Bologna, che sa in cuor suo essere autografa. Allora via di panna, burro e Reggiano.
La versione romana del piatto però, quella prodotta con ingredienti locali più facili da reperire ed economici rispetto al bacon e al parmigiano, ha ormai preso piede; e crescerà sempre di più fino ad oscurare quella che fino a quel momento era stata “la tradizione”, complici i trascorsi di guerra e la lentezza delle comunicazioni: una tradizione di contaminazione e adattamento, di ingegno e disponibilità, come tutte le tradizioni sono state finché non abbiamo deciso di fissarle in una stasi cristallizzata e atrofica.
Adesso, se sia andata davvero così non potremo mai dirlo con certezza; quello che è certo è che la versione sia plausibile, assai più di quella che vorrebbe pastori equipaggiati di dispense mobili o carbonari che vegliavano per mesi i depositi di combustibile; la timeline ha senso e la distribuzione geografica degli indizi avvalora enormemente la “pista americana”.
Pensateci, la prossima volta che vi incazzate perché nella carbonara ci mettono la pancetta, la cipolla o la panna: deponete le armi degli integralisti, dimenticate quello che sapete, e lasciate che l’evoluzione scorra verso il mare.
